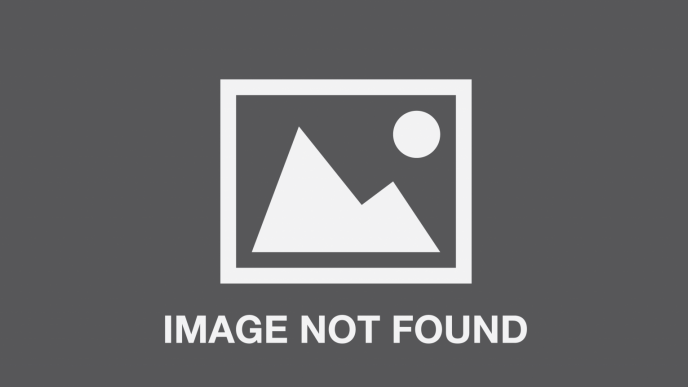Raccontano gli orrori della vita sotto l’Isis: mariti uccisi, ammazzate per strada perché parlavano al cellulare. Una vita da recluse fra fame e bombardamenti
DIBAGAH (Iraq del Nord) – “Se non smetti di piangere, uccido anche te e i tuoi figli”. Siamo in un villaggio a sud di Mosul e la donna che ci sta raccontando la sua storia ha fra le braccia il marito agonizzante. E’ un poliziotto iracheno e un soldato dell’Isis lo ha appena ferito mortalmente davanti ai suoi due figli. Dice la donna: “E’ tornato indietro e gli ha sparato in mezzo agli occhi”. Aisha (usiamo un nome di fantasia per tutelare la donna come faremo per tutte le altre, ndr) racconta questa storia nella sua tenda nel campo di Dibagah, una cinquantina di chilometri a sud di Erbil, dove vivono circa trentamila profughi fuggiti da Mosul e dai villaggi intorno.
Aisha
Ci parla del marito ucciso cinque mesi prima dai miliziani di Daesh. Ha solo 32 anni, ma ne dimostra già una cinquantina. La project manager di Terre des Hommes, la onlus che si occupa di assistenza ai rifugiati nel Kurdistan iracheno che ci ha accompagnato per fare questa intervista, ha la stessa età, ma sembra sua figlia. La sua è una delle tante testimonianze drammatiche di donne arabe che raccontano la loro vita, prigioniere dell’Isis, che abbiamo raccolto nel campo profughi.
Continua Aisha: “Quando sono usciti mio figlio più grande (un ragazzo sui dodici anni presente nella tenda, ndr) è come impazzito. Ha iniziato a rompere tutto. Da allora non è stato più lo stesso”. Ad ascoltare il racconto c’è anche la figlia della donna una ragazzina con grandi occhi scuri che sembra aver assorbito meglio, apparentemente, la tragedia. “C’era tutto quel sangue sul pavimento – racconta la donna – che non voleva andarsene. Io strofinavo, strofinavo, ma la macchia rimaneva. Non ce la facevo più a vederla. Per vivere, andavamo avanti grazie all’aiuto dei vicini. Quando uscivo di casa, dovevo indossare il niqab che mi copriva tutta. Potevo andare fuori per comprare cibo, ma dovevo sempre essere accompagnata da parenti stretti”.
Poi la fuga. “Sono stata aiutata da un miliziano dell’Isis – racconta – che è stato costretto ad arruolarsi, ma si vergognava di stare con loro. Siamo fuggiti di notte. Nei punti scoperti, più visibili, usavamo dei tunnel sotterranei, mentre in altri attraversavamo dei campi minati. Lui sapeva dove erano le mine, altrimenti non ce l’avremmo mai fatta. Un’altra donna, che è fuggita con noi, non è sopravvissuta. Le hanno sparato e l’hanno uccisa”. Poi la lunga marcia fino a Dibagah e la salvezza. “Cerco di essere forte, ma di notte – dice la donna – mentre i miei ragazzi dormono, piango e penso al loro futuro. Non so se tornerò al mio villaggio. L’Isis ha distrutto tutto. Tutto quello che ho, ora, al mondo, sono i miei figli”.
Usciamo dalla tenda e passiamo attraverso il campo disseminato di tende a perdita d’occhio. Le donne cuociono il pane in forni costruiti con il fango. Bambini giocano a pallone in mezzo alla polvere. Dibagah è oramai al completo. Attualmente si stanno costruendo altri campi per ospitare i profughi che fuggono mano a mano che l’esercito avanza per conquistare il centro di Mosul. Entriamo, questa volta, in una povera struttura in muratura e incontriamo un’altra donna.
Khalida
Khalida indossa il niqab. Spuntano fuori solo due occhi scuri, penetranti. Viene anche lei da un villaggio a sud di Mosul. Il marito, che è un soldato dell’esercito iracheno, è fuggito due anni prima di lei, non appena è arrivato l’Isis, altrimenti sarebbe stato sicuramente ucciso. Hanno quattro figli: due femmine e due maschi. Racconta: “Era durissimo vivere sotto l’Isis. Non potevi uscire se non per comprare da mangiare o per andare dal medico. Gli uomini dovevano portare la barba lunga e i pantaloni corti sopra le caviglie. Siamo stati costretti a tagliarli tutti. I jeans erano proibiti. Non potevo neanche parlare al telefono con mio marito. Dovevo farlo di nascosto. Quando lo chiamavo, i miei ragazzi dovevano stare attenti che nessuno arrivasse o mi vedesse. Una volta, mentre andavo all’ospedale, ho visto una donna che è stata uccisa. Le hanno sparato perché al bazar era al cellulare con il marito”.
Poi racconta una cosa che, quando arrivò Daesh due anni fa, molte famiglie sunnite pensarono. “Quando arrivò l’Isis – dice la donna – credevamo che fosse meglio dell’esercito iracheno. Poi, purtroppo, ci siamo dovuti ricredere velocemente”. L’esercito, fra l’altro, è fuggito lasciando le famiglie di Mosul e dei villaggi in balia dell’Isis. Racconta il marito della donna che è di fianco a lei: “Sono scappati e hanno lasciato le armi, le munizioni e ben 27 milioni di dollari in città”. Prima di andare via il marito ci fa vedere le foto della sua casa distrutta. Spera di tornare, ma non sa come farà a ricostruirla. Percorriamo qualche centinaio di metri e arriviamo allo stadio che, su quello che era il campo da calcio, ospita oggi un’altra distesa di tende.
Haniya
Qui incontriamo Haniya. Un viso indurito dalle sofferenze. E’ un po’ introversa. Si vede che non è abituata a parlare con un uomo. Ha 4 figli ed è fuggita da Mosul durante il Ramadan. “Dovevamo coprirci interamente quando andavamo fuori – racconta – e lo potevamo fare solo per comprare da mangiare. Ma eravamo in grado di acquistare veramente poco perché non avevamo soldi. Non riuscivamo neanche a pagare la luce in casa. C’erano bombardamenti continui. Se una donna usciva da sola, senza marito o figli, andava in prigione. Se usavi il cellulare andavi in prigione. Mio cugino è stato fermato. Non sapeva pregare. Allora lo hanno portato in carcere, lo hanno picchiato e lo hanno costretto ad imparare le preghiere. Non potevamo lavorare. Per mangiare facevamo il pane in casa e, di nascosto, lo vendevamo ai nostri vicini”. Aggiunge: “Non voglio tornare là, perché la mia casa è stata distrutta. Spero che Daesh venga annientato presto perché non abbiamo bisogno di qualcuno che, tutto il giorno, ci dica cosa dobbiamo fare e come dobbiamo farlo”.
Leila
Usciamo e passiamo attraverso una struttura, sotto lo stadio, dove dormono alcuni ragazzi. Ci spiegano che hanno trovato rifugio lì perché c’erano delle milizie che li volevano assoldare per farli combattere contro l’Isis. La paga è buona e la tentazione, per questi giovani, che magari devono mantenere una famiglia, è grande. Questi, probabilmente, saranno salvati. Arriviamo nella tenda di Leila che è arrivata fin qui a piedi da Kirkuk con la sua famiglia, il marito e i tre figli. Racconta: “Siamo arrivati qua tre mesi fa. Mio marito, che fa l’insegnante, non poteva lavorare sotto l’Isis. Non c’era cibo. Non potevamo comprare nulla. Un chilo di zucchero costava 50 dollari. Cucinavamo il pane in casa con la farina e l’acqua sporca. Mangiavamo solo quello: pane e acqua. Per cinque mesi abbiamo vissuto così, senza uscire di casa. Poi non ce l’abbiamo più fatta.Siamo fuggiti di notte e ci siamo fatti trenta chilometri a piedi per arrivare fino a questo campo. Se ci avessero scoperto, ci avrebbero uccisi tutti”.
Fuori dalla tenda due ragazzine si avvicinano e chiedono una foto. Sorridono. Poi, improvvisamente, una delle due si fa seria. Non parla. Probabilmente ha subito qualche trauma che le impedisce di comunicare con la voce. Ma basta lo sguardo. Fisso, terreo. Inizia a mimare scene di guerra, esplosioni, gente ferita, zoppicante e sanguinante. La bocca si muove, ma le parole non escono. E, se anche uscissero, probabilmente non sarebbero sufficienti a descrivere l’orrore che deve aver vissuto questa bambina, vittima silenziosa della guerra contro l’Isis che si sta combattendo nella piana di Ninive.
 0
0